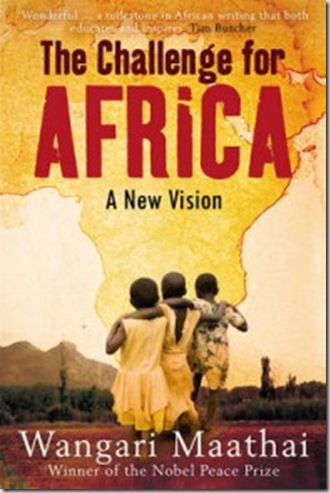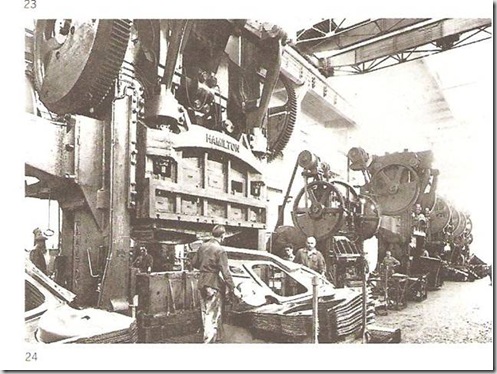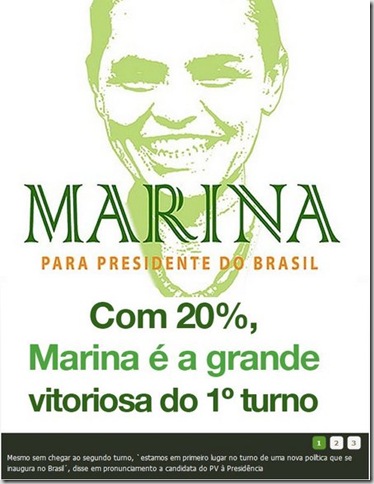Quando l’uranio diventa un investimento
Africa: il continente del fascino e del terrore. Descritta dai viaggiatori europei con sentimenti contrastanti, è la terra dove la paura si fa seduzione: tutto è enorme, tutto è sconvolgente, tutto è paradossalmente affascinante.
La parola Africa viene spesso associata all’idea di povertà: le immagini del degrado più estremo, ad oggi, provengono da questa terra sconfinata. La terra che per i Paesi sviluppati è stata, ed è ancora, fonte di un’immensa ricchezza.
Parliamo di oro, parliamo di diamanti, parliamo di petrolio. Gran parte del continente può essere immaginato come un enorme magazzino di risorse naturali.
Negli ultimi anni, alcuni Paesi africani sono stati nuovamente spinti nell’occhio del ciclone, per via delle possibilità offerte dall’espansione del mercato di un’altra risorsa: l’uranio.
Per una serie di ragioni diverse (1), infatti, è iniziata un’espansione del settore elettronucleare a livello mondiale, che ha spinto in alto la domanda di questo minerale.
La spinta nucleare verso l’Africa
Bastano pochi dati per rendersi conto dell’ampiezza del fenomeno. Ad oggi, esistono al mondo 435 reattori; altri 53 sono stati commissionati, mentre è in discussione o in via di approvazione la costruzione di altri 136. La maggior parte dell’uranio prodotto nel mondo va a confluire in sei Paesi, e precisamente: Stati Uniti (30,21% del consumo mondiale), Francia (15,7%), Giappone (12,37%), Russia (6,39%), Sud Corea (5,88%), Cina (4,45%) (2). Riguardo a quest’ultimo Paese, le previsioni parlano di un aumento della produzione elettronucleare di dieci volte i livelli attuali entro il 2030. Uno sviluppo simile dovrebbe avvenire in India, che, nel 2020, avrà bisogno di una fornitura di uranio pari a dieci volte quella attuale.
Numerosi studi mostrano come le imprese produttrici non siano, per il momento, in grado di fronteggiare questa domanda crescente (3).
È facile immaginare quale sia stato il riflesso di questa situazione: da un lato diventa imperativo, per i Paesi fruitori, assicurarsi le forniture dei prossimi anni; dall’altro le imprese estrattive devono ampliare la propria capacità produttiva, soprattutto attraverso accordi commerciali con i governi dei Paesi produttori. Si tratta di una vera e propria “corsa all’uranio”, il cui buon esito impone la ricerca di nuovi siti e di nuove rotte commerciali.
Sulla scia di queste spinte, alcuni Stati africani sono stati oggetto di un imponente flusso di investimenti: le imprese minerarie stanno portando avanti nuove esplorazioni, nuove negoziazioni; stanno rivalutando depositi già scoperti e mai sfruttati; stanno persino convertendo all’estrazione di uranio alcuni impianti nati per scopi differenti. Oltre che ad un incremento della capacità produttiva, questa tendenza potrebbe essere interpretata come una strategia di minimizzazione dei rischi o anche come una ricerca di licenze a prezzi più bassi.
Qualunque sia la causa, tale strategia ha incontrato l’atteggiamento favorevole della gran parte dei governi locali, in alcuni casi interessati anche all’utilizzo interno del minerale a scopi energetici.
Una lista dei Paesi africani interessati è facilmente reperibile a partire dal sito della World Nuclear Association. Si tratta in tutto di diciassette Paesi, in cui le attività in corso vanno dalla semplice esplorazione all’estrazione vera e propria: i tre più promettenti sono Niger, Namibia e Sud Africa (4), cui si aggiungono Algeria, Botswana, Repubblica Centrafricana, Congo, Gabon, Guinea, Guinea Equatoriale, Malawi, Mali, Mauritania, Marocco, Nigeria, Tanzania, Zambia.
Tutti questi Stati, in un modo o nell’altro, sono stati investiti dall’interesse delle imprese minerarie. Gli investimenti sono provenuti in primo luogo dall’Australia, ed in misura minore dalla Francia, dal Canada, e in qualche caso dalla Cina.
Cerchiamo di capire le dimensioni del fenomeno con l’aiuto di qualche dato.
Tre piccoli giganti Africani
Anzitutto la Namibia: questo stato dell’Africa Meridionale è il quarto produttore mondiale di uranio, con una quota del 10% dell’output mondiale. Ad esempio, è qui che si trova il deposito di Rossing Uranium, il più esteso del mondo. Si tratta di una miniera situata poco lontano da Walvis Bay, importante, oltre che per la sua estensione, per la sua produzione annua, inferiore solo ai depositi di McArthur River in Canada e di Ranger in Australia. Di proprietà della Rio Tinto in compartecipazione con il governo locale (5), dovrebbe essere sfruttabile ancora per dodici anni (6). Si tratta di un deposito esistente dal 1976, le cui risorse accertate superano le 7000 tonnellate di uranio, mentre le risorse stimate superano le 50000 tonnellate. Recentemente ampliato, questo impianto minierario è stato affiancato da quello di Langer Heinrich, della Langer Heinrich Uranium, società facente parte del gruppo australiano Paladin Energy. Le dimensioni del giacimento si aggirano sulle 45000 tonnellate.
Secondo le previsioni, la produzione namibiana dovrebbe quadruplicare nei prossimi cinque anni con l’apertura di nuovi siti, di cui due dovrebbero essere pronti già dal 2011 (7). In effetti, si tratta di un Paese al centro di una lunga serie di progetti, il più importante dei quali è noto come piano Husab. Questo disegno riguarda un’area di 637 kmq, oggetto di esplorazioni a più livelli, in cui sono presenti più depositi. Il più importante di questi è il cosiddetto Rossing South, che si trova, appunto, poco a sud di Rossing, e sembra essere addirittura più promettente di quest’ultimo. L’esplorazione è portata avanti dalla Extract Resources, mentre la Rio Tinto ne detiene una quota minoritaria. Un altro piano che interessa la Namibia è il progetto Etango, della Bannerman Energy. Tutte e tre queste imprese sono australiane; il più grande investimento estero della storia di questo Paese, tuttavia, è stato effettuato nel 2008 da Areva, per la miniera di Trekkopje, vicino Swakopmund (8).
La società francese, però, è attiva soprattutto in Niger: è qua che è stata recentemente inaugurata la costruzione di una nuova, imponente miniera, nella località di Imouraren. L’impianto sarà per un terzo di proprietà del governo; nei progetti di Areva, l’estrazione dovrebbe iniziare nel 2012, raddoppiando la produzione nigerina e facendo del Paese saheliano il secondo produttore mondiale. Si tratta del quarto sito di proprietà della Areva: gli altri tre si trovano nei pressi di Arlit, capoluogo della regione di Agadez, nei pressi della stessa Imouraren.
Una regione calda non solo perché ai confini con il Sahara: anche la Cina ha vi ha intravisto una possibilità di azione. La Somina (Société des Mines d’Azelik), come lo stesso nome suggerisce, è nata per l’estrazione nella località di Azelik, ed è di proprietà della China Nuclear International Uranium Corporation per il 37%, del governo di Niamey per il 33%, della cinese ZXJOY per il 25%, della Korea Resources Corporation per il 5% (9).
Al contrario di quanto accade in Niger e Namibia, l’estrazione di uranio in Sud Africa è rimasta per lungo tempo un’attività collaterale all’estrazione di oro. Attualmente, sono in cantiere vari progetti per sfruttare l’uranio come sottoprodotto di quest’attività. La canadese First Uranium Corporation, ad esempio, lavora su entrambi i fronti: i luoghi di maggiore attività sono la miniera sotterranea di Ezulwini, sia uranifera che aurifera, e l’impianto Mine Waste Solutions in cui vengono trattati gli scarti per ricavarne uranio e oro a basso costo.
Il primo tentativo di costruire una vera e propria miniera di uranio è stato il progetto Dominion Reefs, portato avanti dalla canadese Uranium One e presto fallito (10). Il Sud Africa è attivo anche nella produzione di energia nucleare, con due reattori attivi sul territorio nazionale.
Un continente in fermento
Sebbene Namibia, Niger e Sud Africa rappresentino il luogo di estrazione della maggior parte dell’uranio africano, queste dinamiche svolgono un ruolo importante in tutto il continente, soprattutto in Africa Centrale.
Nel Botswana, ad esempio, è attiva l’australiana ACAP Resources, nel territorio di Letlhakane, in cui sono presenti tre giacimenti: Gorgon, Mokobaesi e Kraken (per un totale di circa 38,000 tonnellate di uranio). All’interno del Paese è attiva un’altra impresa australiana, la Impact Minerals.
Nella Repubblica Centrafricana, Areva ha rilevato la UraMin per sfruttare il giacimento di Bakouma, che dovrebbe contenere circa 38000 tonnellate di uranio. L’impianto è attualmente in fase di sperimentazione, e secondo l’impresa francese l’apertura dovrà attendere ancora quattro o cinque anni. Con l’accordo stipulato nel 2008, Areva ha accettato di cedere il 10% degli utili al governo, che ha ottenuto anche la stesura di un programma di aiuti finanziari.
La Repubblica Democratica del Congo ha alle spalle una storia di intenso sfruttamento, iniziato negli anni Quaranta, e tristemente legato allo sviluppo dei primi ordigni nucleari. Il sito più attivo è stato, fino all’indipendenza, la miniera di Shinkolobwe, nel Katanga. Nel 2009, il governo ha assegnato la licenza esplorativa della regione ad Areva.
Altri Stati stanno cercando di inserirsi nel mercato: il governo della Guinea Equatoriale, ad esempio, ha iniziato degli studi e introdotto un nuovo codice di regolamentazione del settore. In Gabon, pur non esistendo al momento miniere attive, sono attive delle campagne esplorative. L’attività estrattiva gabonese, nel passato, è rimasta legata al Commissariat à l’énergie atomique (CEA) e, soprattutto, alla Cogema (oggi Areva). I depositi più attivi, oggi in gran parte chiusi, si trovavano nei pressi della città di Mounana.
Per nulla secondarie le attività in Africa Orientale, in particolare nello Zambia, dove, dal 2008, il governo locale ha iniziato la cessione delle licenze, aggiornando la legislazione del settore in consultazione con la IAEA. Da citare il progetto Mutanga, sviluppato dalla OmegaCorp e acquisito nel 2007 dalla canadese Denison Mines: è senz’altro uno dei più imponenti, e dovrebbe giungere a compimento entro un paio di anni. Inoltre, mentre l’australiana Equinox Minerals sta mettendo a punto un impianto di estrazione di uranio dalla miniera di rame di Lumwana, una joint venture costituita dalla African Energy Resources e dalla Albidon (anch’esse australiane) sta eseguendo degli studi di fattibilità per i depositi di Njame e Gwabe (progetto Chirundu).
Anche la Tanzania è in fermento: dopo aver scoperto un deposito di circa 5000 tonnellate a Manyoni, l’australiana Uranex ha ottenuto l’approvazione di un progetto minerario a Bahi e ne ha steso un terzo per la zona di Mkuju e Songea. Svariati progetti sono inoltre portati avanti dalla Mantra Resources, anch’essa australiana. Il governo ha annunciato, per il 2010, una revisione della regolamentazione del settore, dimostrandosi inoltre interessato agli impieghi energetici dell’uranio.
In questa regione del continente occorre menzionare anche il Malawi. Nel nord di questo Stato, infatti, il deposito di Kayelekera, scoperto nel 1980 dalla Central Electricity Generating Board of Great Britain (CEGB), è stato gradualmente acquisito dalla Paladin Energy.
Dei tentativi sono portati avanti anche in Africa occidentale; nella Guinea, ad esempio, l’esplorazione è portata avanti dalle australiane Forte Energy (ex Murchison United) e Toro Energy, con risultati incoraggianti intorno a Firawa, nella prefettura di Kissidogou. La Forte Energy è attiva anche in Mauritania, proprietaria del deposito Bir En Nar.
Più di 8000 tonnellate di uranio (11) dovrebbero trovarsi anche in Mali, in cui si trova il deposito di Falea.
La Nigeria ha iniziato nel 2009 un rapporto di cooperazione con la Russia. Inizialmente limitata all’esplorazione e all’estrazione, la collaborazione dei due Stati si è successivamente estesa alla progettazione di un reattore.
Per completare il quadro, occorre citare due Stati del Nordafrica: Algeria e Marocco.
In Algeria esiste un unico deposito, Tahggart, risalente agli anni Settanta. Il governo, che stima la presenza di almeno 26.000 tonnellate di uranio, ha iniziato nel 2009 la cessione delle licenze di esplorazione.
Anche in Marocco, il governo sta cercando di valorizzare gli sforzi effettuati prima del 1982, esplorando le aree di Haute Moulouya, Wafagga e Sirwa. Allo stesso tempo, Areva sta portando avanti delle sperimentazioni sulle potenzialità uranifere dei fosfati, in accordo con l’ufficio governativo competente (Office Cherifien des Phosphates, OCP) (12).
Un sentiero di cambiamento, una lista di opportunità. Ma la storia insegna che non sempre le opportunità sono sufficienti. Occorre che ci sia una classe dirigente in grado di coglierle. Occorrono istituzioni funzionanti e infrastrutture. Occorrono interventi correttivi dei possibili effetti perversi di queste innovazioni.
Corruzione, spinta al ribasso dei salari, smembramento delle strutture sociali, mancanza di controlli sulla sicurezza, inquinamento, conflitti etnici: problemi quanto mai interconnessi, in questa enorme parte di mondo.
Una sola immensa terra, il giardino dell’Eden dove tutto ebbe inizio. Un immenso paradosso, senza fine e senza tempo, dove solo la bellezza sembra destinata a svanire.
Federica Nalli (dottoressa in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Firenze)
Note:
- Vedi anche articolo su Eurasia, “Uranio: il minerale della discordia” di Federica Nalli (http://www.eurasia-rivista.org/6341/uranio-il-minerale-della-discordia )
(2) Elaborazione personale da dati World Nuclear Association
(3) Vedi anche articolo su Eurasia, “Uranio: il minerale della discordia” di Federica Nalli
(4) Vedi anche articolo su Eurasia, “Uranio: il minerale della discordia” di Federica Nalli
(5) La quota detenuta dal governo è del 3% mentre il 10% appartiene alla Industrial Development Corporation of South Africa (IDC), una società del governo Sudafricano.
(6) A. Ruffini,
Uranium plays in Africa, Engineering & Mining Journal, Vol. 210, n 10, Dicembre 2009, Pagg. 76-78
(7) African Business, Feb2010
( 8 ) A. Ruffini,
Uranium plays in Africa, Engineering & Mining Journal, Vol. 210, n 10, Dicembre 2009, Pagg. 76-78
(9) A. Ruffini,
Uranium plays in Africa, Engineering & Mining Journal, Vol. 210, n 10, Dicembre 2009, Pagg. 76-78
(10) A. Ruffini,
Uranium plays in Africa, Engineering & Mining Journal, Vol. 210, n 10, Dicembre 2009, Pagg. 76-78
(11) Etichettate come Inferred Resources, sottocategoria delle Risorse Identificate (IDR)
(12) Gran parte di queste informazioni è reperibile su www.world-nuclear.org
Fonte



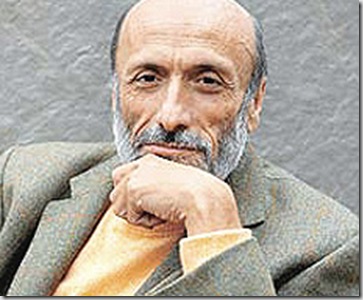







![clip_image001[5] clip_image001[5]](http://lh3.ggpht.com/_vflyDMbzgcU/TLitG21vNTI/AAAAAAAAbTg/rXKSBp_t8qE/clip_image001%5B5%5D%5B3%5D.jpg?imgmax=800)
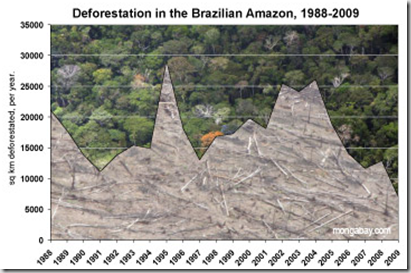
![clip_image001[5] clip_image001[5]](http://lh4.ggpht.com/_vflyDMbzgcU/TLitMpEJfqI/AAAAAAAAbUA/Xs9O0eBm2vU/clip_image001%5B5%5D_thumb%5B1%5D.gif?imgmax=800)

![clip_image002[4] clip_image002[4]](http://lh5.ggpht.com/_vflyDMbzgcU/TLH0gCrHU_I/AAAAAAAAa68/p-YECjR3_mI/clip_image002%5B4%5D_thumb%5B2%5D.jpg?imgmax=800)